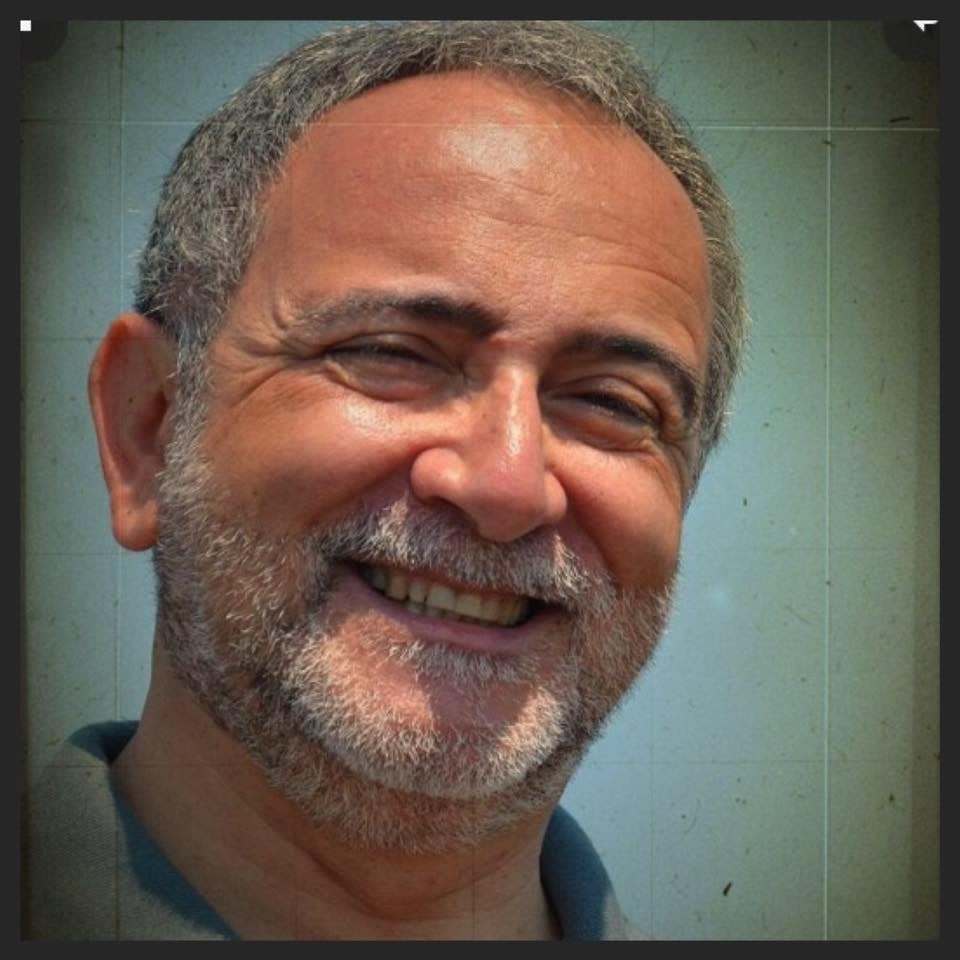La porno dipendenza
La visione di contenuti sessualmente espliciti o pornografia è diventata sempre più comune.
Tuttavia, molte persone non prevedono o si aspettano che l’uso della pornografia influenzerà negativamente le loro vite.
In particolare, il rapporto di coppia può essere influenzato negativamente dalla pornografia.
Sebbene alcune ricerche suggeriscano che l’uso della pornografia in coppia possa avere risultati positivi, come la volontà di provare nuovi comportamenti sessuali o una maggiore intimità sessuale, altre ricerche hanno scoperto molti più potenziali impatti negativi.
Questi impatti negativi possono includere problemi di comunicazione, insoddisfazione sessuale, infedeltà emotiva, ridotta fiducia e problemi di autostima.
Se una relazione è stata ferita dalla pornografia, ci sono passi che possono essere presi per guarire la relazione.
Questi passi possono includere la comunicazione aperta e onesta tra i partner, la ricerca di aiuto professionale come la terapia di coppia e l’impegno a lavorare insieme per superare le conseguenze negative dell’uso della pornografia.
Impatti negativi
La pornografia può avere conseguenze negative sia per l’utente che per il suo partner intimo. I possibili effetti dannosi per l’utente possono includere la dipendenza, l’isolamento, l’aumento dell’aggressività, le convinzioni e le percezioni distorte sulle relazioni e sulla sessualità, i sentimenti negativi su se stessi e la trascuratezza di altre aree della loro vita.
Questi effetti possono anche influenzare negativamente i rapporti familiari e di coppia.
Nel contesto delle relazioni intime di coppia, la pornografia può avere impatti negativi, tra cui:
- La difficoltà dell’utente ad eccitarsi sessualmente senza pornografia.
- La riduzione del numero di esperienze sessuali con il partner.
- L’aumento dei comportamenti di infedeltà.
- La sensazione di minaccia sessuale del partner.
- Il giudizio su alcune attività sessuali desiderate dall’utente.
- La minore soddisfazione sessuale e la vicinanza emotiva.
- La diminuzione della fiducia nella relazione.
- La minore stabilità della relazione.
- La comunicazione meno positiva e la maggiore aggressività psicologica tra i partner.
- La preoccupazione per l’esposizione dei bambini al materiale pornografico.
Passi per la guarigione di una relazione ferita dalla pornografia
Guarire una relazione ferita dalla pornografia può essere un processo lungo e complesso, ma ci sono passi che le coppie possono seguire per iniziare il percorso di guarigione.
In primo luogo, è importante che entrambi i partner siano disposti ad affrontare il problema e ad impegnarsi nella riparazione della relazione. Ciò richiede onestà e apertura nella comunicazione, così come la volontà di ascoltare l’altro senza giudicare.
In secondo luogo, è necessario identificare il ruolo che la pornografia ha avuto nella relazione, comprese le conseguenze che ha avuto su entrambi i partner. Questo può essere doloroso, ma è importante per una comprensione completa della situazione.
In terzo luogo, le coppie possono cercare l’aiuto di un terapeuta specializzato in questioni relative alla pornografia e alla sessualità.
Un terapeuta può aiutare a sviluppare un piano di guarigione personalizzato, che può includere la costruzione di una relazione più intima e significativa, la riscoperta di interessi comuni e attività condivise e la creazione di nuove routine intime.
Infine, è importante continuare a lavorare sulla relazione e sulla comunicazione, anche dopo aver fatto progressi significativi.
La guarigione richiede tempo, impegno e pazienza, ma può portare a una relazione più forte e soddisfacente.
Potenziali effetti positivi dell’utilizzo della pornografia in coppia
È importante sottolineare che l’utilizzo della pornografia in coppia può anche avere effetti positivi sulla relazione.
Quando entrambi i partner sono aperti e consenzienti nell’utilizzo della pornografia, può fungere da una fonte di ispirazione per esplorare nuove fantasie e desideri sessuali insieme.
Inoltre, l’utilizzo della pornografia può aiutare a migliorare la comunicazione sessuale all’interno della coppia, aprendo la discussione su ciò che piace e ciò che non piace.
In alcuni casi, l’utilizzo della pornografia può anche aumentare la complicità e l’intimità emotiva all’interno della coppia, creando uno spazio sicuro in cui entrambi i partner si sentono liberi di esplorare la loro sessualità.
Tuttavia, è importante che l’uso della pornografia in coppia sia sempre consensuale e rispettoso dei desideri e dei limiti di entrambi i partner.
Conclusioni
In conclusione, la pornografia può avere un impatto significativo sulle relazioni intime e può portare a sentimenti di distanza, mancanza di fiducia e disagio.
Tuttavia, con la giusta attenzione e impegno, è possibile guarire una relazione ferita dalla pornografia.
È importante che entrambi i partner siano disposti ad affrontare il problema insieme, comunicare apertamente e cercare l’aiuto di un professionista se necessario.
Valentina Cicerone
Tirocinante di psicologia preso
Studio BURDI

Disforia di genere: quando l’identità non corrisponde al corpo
Cos’è la disforia di genere?
La disforia di genere è una condizione in cui si sperimenta un conflitto tra il proprio sesso assegnato alla nascita e il genere con cui ci si identifica. Questa situazione può causare un grande disagio e far sentire a disagio la persona nel proprio corpo.
Le persone che vivono la disforia di genere potrebbero sentirsi inclini a esprimere il proprio genere in modo diverso da quello imposto dalla società. Questo potrebbe significare adottare un abbigliamento differente, utilizzare i pronomi e frequentare i bagni pubblici associati al proprio genere preferito, sottoporsi ad interventi medici o chirurgici specifici, o una combinazione di queste opzioni.
La disforia di genere non è una malattia mentale, ma alcune persone possono sviluppare problemi di salute mentale a causa della disforia di genere.
Segni di disforia di genere
La disforia di genere può manifestarsi in segni visibili nell’aspetto, nel comportamento o negli interessi delle persone che ne soffrono.
Inoltre, coloro che sperimentano la disforia di genere possono mostrare segni di disagio o di angoscia, come bassa autostima, ritirarsi o isolarsi socialmente, depressione o ansia, correre rischi inutili o trascurare il proprio benessere personale.
I sintomi della disforia di genere possono variare da persona a persona, ma in generale, possono essere divisi in due categorie principali: sintomi psicologici e sintomi fisici.
I sintomi psicologici possono includere:
- Una forte e persistente sensazione di disagio o sconforto legato al proprio sesso biologico assegnato alla nascita.
- Sentirsi disconnessi o estranei dal proprio corpo o dal proprio genere.
- Un forte desiderio di esprimersi come il genere opposto a quello assegnato alla nascita.
- Sentirsi ansiosi, depressi o emotivamente instabili a causa della propria identità di genere.
- Ritirarsi o isolarsi socialmente per paura di essere giudicati o non accettati.
I sintomi fisici possono includere:
- La volontà di modificare il proprio aspetto fisico per adattarlo al genere con cui si identificano. Ciò può includere la ricerca di interventi chirurgici, ormonali o altri metodi per modificare le caratteristiche sessuali primarie o secondarie.
- L’utilizzo di abiti o accessori che riflettono il genere opposto a quello assegnato alla nascita.
- L’evitare di mostrare parti del corpo che sono associati al genere assegnato alla nascita (ad esempio, i pettorali per una persona assegnata come maschio alla nascita).
È importante sottolineare che non tutte le persone con disforia di genere sperimentano tutti questi sintomi e che la gravità dei sintomi può variare da leggera a grave. Inoltre, questi sintomi possono presentarsi in qualsiasi momento della vita, ma spesso iniziano a manifestarsi in età precoce.
Cosa causa la disforia di genere?
Non si conosce ancora con precisione la causa esatta della disforia di genere.
Lo sviluppo del genere umano è un processo complesso e ci sono ancora molte cose che non sono completamente note o comprese.
Inoltre, è importante sottolineare che la disforia di genere non è correlata all’orientamento sessuale. Le persone che ne soffrono possono identificarsi come eterosessuali, omosessuali, bisessuali o di qualsiasi altro orientamento sessuale.
Trattamento
Il trattamento della disforia di genere dipende dalle esigenze e dalle preferenze individuali della persona che ne soffre. Alcune persone scelgono di non cercare alcun tipo di trattamento, mentre altre possono optare per un approccio medico, psicologico o una combinazione di entrambi.
Il trattamento medico può includere la terapia ormonale, che prevede l’utilizzo di ormoni per alterare le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del corpo. In alcuni casi, possono essere prescritti farmaci per sopprimere le caratteristiche sessuali primarie o secondarie indesiderate.
La terapia chirurgica può anche essere un’opzione per alcune persone che desiderano modificare le loro caratteristiche sessuali primarie, come ad esempio la mastectomia per le donne transessuali o la chirurgia di ricostruzione del seno per gli uomini transessuali.
Oltre alla terapia medica, la terapia psicologica può essere utilizzata per aiutare le persone a gestire i sintomi della disforia di genere e ad affrontare le sfide che possono incontrare nella loro vita quotidiana. La terapia può includere la terapia cognitivo-comportamentale, la terapia di sostegno e la terapia familiare.
Valentina Cicerone
Tirocinante di psicologia preso
Studio BURDI
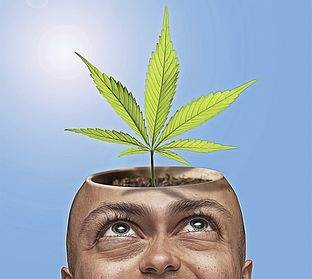
Dipendenza dalla Cannabis: Effetti sulla Salute
Con l’aumento dell’uso di cannabis tra gli adolescenti e gli adulti, è cruciale esaminare gli effetti che questa sostanza può comportare sulla salute.
Cos’è la cannabis?
La cannabis è una pianta psicoattiva originaria dell’Asia centrale e meridionale, la cui popolarità è cresciuta enormemente negli ultimi decenni, sia a scopo terapeutico che ricreativo. La sostanza attiva della cannabis, il THC, è nota per i suoi effetti psicoattivi che possono produrre una sensazione di rilassamento ed euforia.
Tuttavia, l’uso eccessivo di cannabis può avere un impatto significativo sulla salute mentale e fisica dell’individuo. In questo articolo, esploreremo gli effetti che l’uso della cannabis ha sulla mente e sul corpo, analizzando sia i potenziali benefici che i rischi associati a questa sostanza stupefacente.

In che modo la cannabis influisce sulla tua mente e sul tuo corpo?
La cannabis può avere effetti positivi e negativi sulla salute mentale e fisica. Può ridurre il dolore e l’infiammazione e aiutare in alcune convulsioni, ma può anche causare ansia, depressione e paranoia.
La cannabis può influire sulla memoria, sull’apprendimento e sulla capacità di svolgere compiti complicati. Il principale cannabinoide psicoattivo della pianta, il THC, può influenzare l’umore e la percezione sensoriale.
L’uso eccessivo di cannabis può aumentare il rischio di cancro, di infarto e di problemi al sistema respiratorio e cardiovascolare. Inoltre, può ridurre la fertilità maschile e femminile.
È importante considerare questi rischi prima di utilizzare la cannabis e fare attenzione al suo utilizzo.
Ecco un elenco degli effetti collaterali dell’uso di cannabis:
- Secchezza delle fauci: la cannabis può ridurre la produzione di saliva, causando una sensazione di secchezza delle fauci.
- Rosso degli occhi: la cannabis può dilatare i vasi sanguigni, anche quelli negli occhi, causando una sensazione di arrossamento.
- Ansia: alcune persone possono provare ansia dopo aver consumato cannabis, specialmente se la dose è elevata.
- Paranoia: l’uso eccessivo di cannabis può causare paranoia, un disturbo caratterizzato da pensieri eccessivamente negativi o irrazionali.
- Allucinazioni: alcune persone possono sperimentare allucinazioni dopo aver consumato cannabis. Questo effetto è più comune nei consumatori abituali o in quelli che utilizzano cannabis ad alta concentrazione.
- Diminuzione della coordinazione e della capacità di concentrazione: la cannabis può influire sulla capacità di coordinazione e di concentrazione.
- Aumento dell’appetito: la cannabis può aumentare l’appetito, causando una maggiore voglia di cibo.
- Sonnolenza: la cannabis può causare sonnolenza o stanchezza, specialmente se assunta in dosi elevate o prima di coricarsi.
- Dipendenza psicologica e fisica: l’uso eccessivo o abituale di cannabis può causare dipendenza psicologica e fisica. La dipendenza psicologica si verifica quando una persona non può immaginare la vita senza cannabis, mentre la dipendenza fisica si verifica quando una persona sperimenta sintomi di astinenza quando cerca di smettere di usare cannabis.
- Disturbi del sonno: l’uso di cannabis può disturbare il ciclo del sonno, causando problemi di sonno come difficoltà ad addormentarsi o svegliarsi frequentemente durante la notte.
- Disturbi fisici: l’uso di cannabis può causare disturbi fisici come mal di testa, vertigini, nausea, vomito e aumento della frequenza cardiaca.
- Depressione: alcune persone possono sperimentare sintomi di depressione dopo aver consumato cannabis, specialmente se sono già predisposte alla malattia.

Impatto sulla vita sociale
La dipendenza dalla cannabis può avere un forte impatto sulla vita sociale e relazionale di una persona. L’uso eccessivo di questa sostanza può portare a problemi comportamentali, emotivi e cognitivi che possono influenzare negativamente le relazioni personali, sociali e professionali.
In particolare, l’isolamento sociale può essere una conseguenza comune dell’uso eccessivo di cannabis, poiché le persone tendono a preferire il consumo di sostanze da sole, piuttosto che partecipare ad attività sociali e relazionali.
Inoltre, l’acquisto di cannabis può diventare costoso, causando problemi finanziari come mancanza di denaro per le necessità quotidiane o debiti.
L’uso eccessivo di cannabis può anche influire negativamente sulle prestazioni lavorative e scolastiche, poiché può causare difficoltà nel svolgimento di compiti complessi e una diminuzione della capacità di pensare in modo razionale e chiaro.
L’abuso di cannabis può anche aumentare il rischio di sviluppare problemi di salute mentale, come ansia e depressione, che possono influenzare negativamente la vita sociale e relazionale, conducendo All’ isolamento.
Infine, l’uso di cannabis è illegale in molti paesi, pertanto chi ne fa uso possono può incorrere in problemi legali, come arresti e condanne penali.
La cannabis può creare dipendenza
La cannabis è una droga molto diffusa, anche se viene spesso considerata leggera, di fatto non lo è per i suoi effetti nocivi e di dipendenza. Questa dipendenza può essere sia psicologica che fisica.
La dipendenza psicologica si verifica quando una persona non può immaginare la propria vita senza cannabis, mentre la dipendenza fisica si verifica quando una persona sperimenta sintomi di astinenza quando cerca di smettere di usare cannabis.
I sintomi di astinenza possono essere irritabilità, insonnia, sudorazione eccessiva e perdita di appetito. Inoltre, la dipendenza dalla cannabis può avere un impatto negativo sulla salute mentale e sul benessere generale dell’individuo, causando ansia, depressione e paranoie.
Se si sospetta di avere una dipendenza da cannabis, è importante cercare aiuto professionale. La dipendenza psicologica può essere difficile da superare da soli. Cercare il supporto di amici e familiari può aiutare, ma spesso è necessario rivolgersi a un professionista per ricevere il sostegno adeguato.
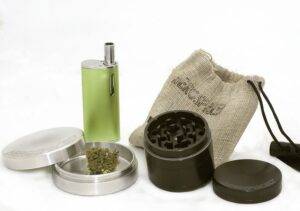
Valentina Cicerone
Tirocinante di psicologia preso
Studio BURDI

Eccessi di shopping: quando l’acquisto diventa una dipendenza
Cos’è lo shopping compulsivo?
Lo shopping compulsivo, o dipendenza dallo shopping, è un disturbo caratterizzato da un’eccessiva tendenza all’acquisto, che può influenzare negativamente la qualità della vita di una persona.
Mentre alcune persone con questa condizione sviluppano una preferenza per determinati prodotti, come orologi o cibo, altri comprano in modo compulsivo senza restrizioni.
In ogni caso, il disturbo dell’acquisto compulsivo può avere effetti negativi sulle finanze personali e sulle relazioni sociali.
Pur non essendo ufficialmente riconosciuto dal DSM, il disturbo da acquisto compulsivo è considerato un problema legittimo dai professionisti della salute mentale. Questa condizione può avere un impatto duraturo sugli individui e sui loro cari, e le opzioni di trattamento sono simili a quelle per altre dipendenze comportamentali.
Segni distintivi della spesa compulsiva
Ecco alcuni possibili segni distintivi della spesa compulsiva:
- Acquisti impulsivi e irrazionali: la persona che soffre di spesa compulsiva può fare acquisti senza una reale necessità o senza considerare le conseguenze finanziarie.
- Preoccupazione eccessiva per lo shopping: chi soffre di spesa compulsiva può passare molto tempo a pensare al prossimo acquisto o a pianificare i propri acquisti.
- Sensazione di sollievo temporaneo: l’acquisto può portare una sensazione di sollievo temporaneo, ma che viene seguita da una sensazione di colpa o di rimorso.
- Difficoltà a resistere all’impulso di acquistare: la persona che soffre di spesa compulsiva può avere difficoltà a resistere all’impulso di acquistare, anche se non ci sono soldi sufficienti o se l’acquisto non è necessario.
- Acquisti ripetitivi o ossessivi: la persona che soffre di spesa compulsiva può acquistare lo stesso prodotto in modo ripetitivo o ossessivo, o può avere un’ossessione per determinati negozi o marche.
- Nascondere o mentire sui propri acquisti: chi soffre di spesa compulsiva può nascondere gli acquisti ai propri cari o mentire sui costi reali degli acquisti.
- Utilizzo di carte di credito o prestiti: la persona che soffre di spesa compulsiva può utilizzare carte di credito o chiedere prestiti per finanziare gli acquisti, anche se non ci sono i soldi per pagarli.
- Sensazione di perdita di controllo: la persona che soffre di spesa compulsiva può avere la sensazione di perdere il controllo sulla propria vita e sui propri acquisti.
- Problemi finanziari o debiti: la spesa compulsiva può portare a gravi problemi finanziari, come indebitamento e difficoltà a pagare le proprie bollette o le proprie spese quotidiane.
Fattori di rischio
Ci sono diversi fattori di rischio che possono contribuire allo sviluppo di uno shopping compulsivo:
- Ansia e depressione: le persone con disturbi d’ansia o depressione possono utilizzare lo shopping come mezzo per alleviare i loro sintomi.
- Bassa autostima: le persone con bassa autostima possono cercare di aumentare il loro senso di autostima attraverso l’acquisto di beni materiali.
- Storia di abuso: le persone che hanno subito abusi fisici, sessuali o emotivi possono utilizzare lo shopping come mezzo di fuga o di conforto.
- Storia familiare: le persone che hanno familiari con problemi di dipendenza, tra cui dipendenza dallo shopping, possono essere più inclini a sviluppare lo stesso comportamento.
- Problemi finanziari: le persone che si trovano in difficoltà finanziarie possono utilizzare lo shopping come mezzo per affrontare lo stress e la tensione.
- Pressione sociale: la pressione dei social media e della società in generale per avere e mostrare beni di consumo costosi può portare alcune persone a sviluppare comportamenti di acquisto compulsivo.
- Accesso facile al credito: la disponibilità di carte di credito con limiti di credito elevati può facilitare l’acquisto di beni anche quando non si dispone di denaro sufficiente per farlo.
Come fermare lo shopping compulsivo
Fermare lo shopping compulsivo può essere una sfida, ma ci sono alcune strategie che possono aiutare a gestire questa dipendenza:
- Identificare le emozioni negative che scatenano lo shopping compulsivo: l’ansia, la depressione, la noia o la solitudine possono essere alla radice dello shopping compulsivo. Identificare queste emozioni e trovare modi alternativi per gestirle può aiutare a ridurre l’impulso di fare acquisti.
- Creare un budget e rispettarlo: è importante stabilire un limite di spesa realistico e rispettarlo. Evitare di utilizzare le carte di credito e optare per metodi di pagamento alternativi, come il contante o le carte prepagate.
- Fare una lista della spesa e rispettarla: prima di fare acquisti, fare una lista dettagliata degli articoli necessari e rispettarla. Evitare di acquistare oggetti impulsivamente che non sono nella lista.
- Evitare di frequentare luoghi di shopping: evitare di frequentare centri commerciali e negozi può aiutare a ridurre l’impulso di fare acquisti.
- Chiedere aiuto: il supporto di amici e familiari può essere utile per affrontare lo shopping compulsivo. Inoltre, rivolgersi a uno psicologo specializzato in dipendenze può aiutare ad affrontare e gestire la dipendenza.
Ricorda che fermare lo shopping compulsivo richiede tempo e impegno, ma è possibile gestirlo e superarlo con le giuste strategie e il supporto adeguato.
Quando cercare un aiuto professionale
Le dipendenze comportamentali possono essere fonte di vergogna e disagio per molte persone, il che può renderle riluttanti a cercare aiuto.
Tuttavia, se stai lottando per controllare il tuo comportamento di shopping compulsivo e senti che sta influenzando la tua vita quotidiana, potrebbe essere il momento di considerare la possibilità di cercare aiuto professionale.
Inizia cercando un terapeuta specializzato nel trattamento delle dipendenze comportamentali.
Molte di queste persone utilizzano tecniche terapeutiche cognitive e comportamentali per aiutare i clienti a identificare i fattori scatenanti che portano al comportamento di shopping compulsivo e implementare strategie di coping alternative.
Valentina Cicerone
Tirocinante di psicologia presso
Studio BURDI

ANORGASMIA
Anorgasmia
quando il piacere sessuale è fuori portata
L’anorgasmia è un disturbo sessuale che colpisce sia gli uomini che le donne. Si tratta della difficoltà o impossibilità di raggiungere l’orgasmo durante l’attività sessuale.
L’anorgasmia può essere causata da una serie di fattori, sia psicologici che fisici. In questo articolo, esploreremo le cause, i sintomi e i trattamenti per l’anorgasmia.
L’anorgasmia può colpire sia gli uomini che le donne di tutte le età. Non esiste un profilo specifico di persona che può soffrire di questo disturbo sessuale, in quanto le cause possono essere molteplici e variano da persona a persona.
Alcuni studi suggeriscono che l’anorgasmia è più comune nelle donne rispetto agli uomini, ma ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le donne spesso hanno una maggiore difficoltà a parlare apertamente dei loro problemi sessuali rispetto agli uomini.
In ogni caso, l’anorgasmia può avere un impatto significativo sulla qualità della vita sessuale e sul benessere psicologico e fisico della persona che ne soffre, motivo per cui è importante cercare il supporto di un professionista qualificato se si sospetta di avere questo disturbo.
Cause dell’anorgasmia
L’anorgasmia può essere causata da una varietà di fattori.
Tra le cause psicologiche, ci sono problemi di ansia, depressione, stress, insicurezza sessuale, traumi o abusi sessuali, problemi di relazione e di comunicazione con il partner, e altro ancora.
Le cause fisiche possono includere problemi ormonali, malattie o patologie che colpiscono il sistema riproduttivo, l’uso di farmaci specifici, e altro ancora.
Il sintomo principale dell’anorgasmia è la difficoltà o l’incapacità di raggiungere l’orgasmo durante l’attività sessuale.
Tuttavia, ci sono anche altri sintomi che possono accompagnare l’anorgasmia, come la mancanza di desiderio sessuale, la difficoltà a mantenere l’erezione (negli uomini), il dolore durante i rapporti sessuali, e altro ancora.
Anorgasmia nell’uomo
L’anorgasmia nell’uomo si verifica quando egli non riesce a raggiungere l’orgasmo durante l’attività sessuale.
Questa condizione può essere causata da una serie di fattori, come problemi fisici, psicologici o relazionali.
Ad esempio, problemi fisici come la disfunzione erettile, l’ipertrofia prostatica benigna o l’uso di alcuni farmaci possono causare anorgasmia nell’uomo.
D’altra parte, problemi psicologici come lo stress, l’ansia, la depressione, la bassa autostima o il trauma sessuale possono anche causare anorgasmia nell’uomo.
Anorgasmia nella donna
L’anorgasmia nella donna si riferisce all’incapacità di raggiungere l’orgasmo durante l’attività sessuale.
Questa condizione può essere causata da una varietà di fattori, tra cui problemi fisici, psicologici o relazionali.
Tra i problemi fisici che possono causare anorgasmia nelle donne, ci sono la disfunzione sessuale femminile, la menopausa, la chirurgia pelvica o l’endometriosi.
Allo stesso modo, problemi psicologici come l’ansia da prestazione, la depressione, il trauma sessuale o la scarsa autostima possono influire sulla capacità di una donna di raggiungere l’orgasmo.
Tipologie di anorgasmia
Esistono alcune classificazioni comuni dell’anorgasmia:
- Anorgasmia primaria e anorgasmia secondaria: l’anorgasmia primaria si riferisce all’incapacità di raggiungere l’orgasmo dalla prima attività sessuale, mentre l’anorgasmia secondaria si verifica quando una persona che in passato ha sperimentato orgasmi inizia ad avere difficoltà a raggiungerli.
- Anorgasmia generale e anorgasmia situazionale: l’anorgasmia generale si riferisce all’incapacità di raggiungere l’orgasmo in qualsiasi situazione sessuale, mentre l’anorgasmia situazionale si verifica solo in alcune situazioni.
- Anorgasmia primaria generalizzata e anorgasmia primaria selettiva: l’anorgasmia primaria generalizzata si riferisce all’incapacità di raggiungere l’orgasmo in qualsiasi forma di attività sessuale, mentre l’anorgasmia primaria selettiva si verifica solo in alcune forme di attività sessuale.
- Anorgasmia organica e anorgasmia psicogena: l’anorgasmia organica si riferisce a cause fisiche della condizione, come la disfunzione sessuale femminile o la disfunzione erettile, mentre l’anorgasmia psicogena è causata da fattori psicologici come lo stress, l’ansia o la depressione.
La classificazione dell’anorgasmia è importante per aiutare a identificare la causa sottostante e fornire il trattamento appropriato.
La valutazione di un medico o di uno specialista in sessuologia può aiutare a determinare la migliore opzione di trattamento per la condizione.
Impatto sulla vita
Chi soffre di anorgasmia può sperimentare una vasta gamma di emozioni e sensazioni. Gli uomini e le donne che soffrono di anorgasmia possono sentirsi frustrati e delusi per non essere in grado di raggiungere l’orgasmo durante l’attività sessuale, soprattutto se si sentono in colpa o inadeguati.
Inoltre, le persone che soffrono di anorgasmia possono provare un senso di perdita di controllo durante l’attività sessuale e una mancanza di piacere e di gratificazione.
Questi sentimenti possono portare a una ridotta autostima, ad un aumento dell’ansia e dello stress durante l’attività sessuale e ad un’insoddisfazione sessuale generale.
In alcuni casi, l’anorgasmia può anche portare ad una ridotta libido, alla disfunzione erettile negli uomini o alla secchezza vaginale nelle donne.
Questi sintomi possono a loro volta portare ad una riduzione dell’interesse per l’attività sessuale e ad un maggior rischio di evitamento del sesso.
È importante sottolineare che ogni persona può sperimentare l’anorgasmia in modo diverso e che le emozioni e le sensazioni associate possono variare da persona a persona.
In ogni caso, l’anorgasmia può avere un impatto significativo sulla vita sessuale e sulla salute mentale delle persone che ne soffrono.
Trattamenti per l’anorgasmia
Il trattamento dell’anorgasmia dipende dalle cause del disturbo.
In alcuni casi, il problema può essere risolto con la psicoterapia sessuologica per individuare le cause sottostanti, parallelamente avvicinando il soggetto a pratiche fiosioterapiche autogestite, attraverso stimolazioni auto erotiche, verso le quali potrebbe aver sviluppato forme di inibizioni dovute ad imbarazzi e vergogne, maturate lungo il suo percorso di vita, attraverso modalita educative disfunzionali.
In altri casi, possono essere necessari farmaci per trattare problemi ormonali o altre malattie fisiche.
In alcuni casi, è possibile utilizzare la stimolazione dei nervi genitali tramite vibrazioni o altri dispositivi.
Infine, possono essere utili esercizi per rinforzare i muscoli pelvici e migliorare la funzione sessuale.
Conclusioni
È importante notare che l’anorgasmia non deve essere un tabù o fonte di vergogna, e che molte persone ne soffrono.
Con il supporto adeguato, è possibile superare questo disturbo e godere di una vita sessuale soddisfacente.
In sintesi, se si sperimenta l’anorgasmia, è importante parlare con un medico o un professionista qualificato per discutere delle opzioni di trattamento disponibili e trovare la soluzione migliore per migliorare la propria vita sessuale e la propria salute mentale.
Valentina Cicerone
Tirocinante di psicologia presso
Studio BURDI
Continua
CLITORIDIMIA
Clitoridinia
comprendere il dolore al clitoride e trovare sollievo
La clitorodinia è un disturbo che causa dolore al clitoride, manifestandosi attraverso sensazioni di bruciore, pulsazioni o pungenti.
Le cause del dolore possono essere molteplici, ad esempio lesioni, infezioni o danni all’area.
Inoltre, può essere causata da problemi psicologici come lo stress, l’ansia e la depressione che possono influire sulla sensibilità del clitoride e causare dolore.
Tuttavia, è importante sottolineare che la maggior parte dei casi di clitorodinia possono essere trattati con successo attraverso farmaci, terapia psicologica, terapia fisica o modifiche dello stile di vita.
È quindi possibile trovare sollievo dal dolore al clitoride e migliorare la propria qualità di vita.
Come si sente il dolore al clitoride?
Il dolore al clitoride è un disturbo che può essere lieve o grave, ma comunque molto fastidioso e influire sulla vita quotidiana. Il clitoride è una zona estremamente sensibile del corpo femminile, in quanto contiene migliaia di nervi. Il dolore può essere descritto come una sensazione di bruciore, pulsante, prurito o addirittura come un colpo o uno spasmo.
Il dolore può diffondersi in tutta la regione genitale o nella pelvi, e può essere accentuato da attività come indossare abiti attillati, fare la doccia o fare pipì.
Le persone che soffrono di clitoridinia possono sperimentare difficoltà a fare esercizio, camminare o stare seduti per lunghi periodi di tempo. Inoltre, molti evitano i rapporti sessuali e hanno problemi nelle relazioni intime.
Se il dolore al clitoride è causato da un’infezione, possono verificarsi altri sintomi come febbre, brividi o dolori muscolari. In rari casi, il dolore al clitoride può essere un segnale di un’emergenza medica e richiedere assistenza immediata.
È importante consultare il proprio medico per valutare le possibili cause del dolore e trovare il giusto trattamento per alleviarlo.
Cause della clitoridinia
Il dolore al clitoride può avere diverse cause. Una delle più comuni è rappresentata dalle perle di cheratina, che si formano quando le normali secrezioni del clitoride si induriscono.
Altre possibili cause possono essere:
- Infezioni vaginali: alcune infezioni, come la candida o la vaginosi batterica, possono causare dolore al clitoride
- Lesioni o traumi: un colpo o una caduta possono causare danni al clitoride e provocare dolore
- Patologie ginecologiche: alcune patologie, come la endometriosi o la vulvodinia, possono causare dolore al clitoride
- Problemi psicologici: lo stress, l’ansia e la depressione possono influire sulla sensibilità del clitoride e causare dolore
Trattamenti per la clitoridinia
Esistono diverse opzioni terapeutiche per trattare la clitoridinia, a seconda della causa sottostante. Tra i trattamenti più comuni possiamo citare:
- Terapia farmacologica: farmaci antinfiammatori, antifungini o antidolorifici possono essere prescritti per alleviare il dolore
- Terapia ormonale: in alcuni casi, la clitoridinia può essere causata da squilibri ormonali, e una terapia ormonale può aiutare a ripristinare l’equilibrio
- Terapia psicologica: se il dolore è causato da problemi psicologici, come lo stress o l’ansia, una terapia psicologica può aiutare a ridurre il dolore
Impatto sulla vita della donna
La clitoridinia, o dolore al clitoride, può avere un impatto significativo sulla vita delle donne che ne soffrono. Il dolore può essere costante o intermittente e può variare in intensità da lieve a grave. Questo può interferire con l’attività sessuale, causando difficoltà nella stimolazione del clitoride e rendendo l’orgasmo doloroso o impossibile.
Inoltre, il dolore al clitoride può interferire con l’attività quotidiana, rendendo scomodo indossare indumenti attillati o fare attività fisica. Alcune donne potrebbero anche sentirsi imbarazzate o imbarazzate a parlare del loro dolore con un medico o un partner sessuale, il che potrebbe impedire loro di ricevere il supporto di cui hanno bisogno.
Per questo motivo, è importante che le donne che soffrono di clitoridinia parlino con il loro medico per identificare la causa sottostante del dolore e trovare un trattamento appropriato. Ci sono molte opzioni di trattamento disponibili, tra cui cambiamenti nello stile di vita, terapia fisica, terapia psicologica, farmaci e interventi chirurgici in casi rari.
Una volta che la causa del dolore viene identificata e trattata, molte donne sono in grado di gestire o eliminare il loro dolore e tornare a una vita sessuale e quotidiana più confortevole.
Valentina Cicerone
Tirocinante di psicologia presso
Studio BURDI
Continua
IL VAGINISMO
Quando il corpo dice no: la verità sul vaginismo e come superarlo
È risaputo che il sesso sia un’esperienza piacevole, divertente e ovviamente una della cose più belle in una relazione intima.
Sfortunatamente però per alcune persone il sesso è causa di molto stress e angoscia in quanto può rappresentare un esperienza dolorosa o in alcuni casi addirittura impossibile.
La causa principale di un rapporto sessuale doloroso per le donne è il vaginismo.
Il vaginismo è una condizione che colpisce le donne e che si caratterizza dalla contrazione involontaria dei muscoli vaginali durante il rapporto sessuale o durante la penetrazione. Tale contrazione può rendere il rapporto sessuale molto doloroso o impossibile.
Il vaginismo può avere un impatto significativo sulla vita di una donna, sia a livello fisico che psicologico.
Fisicamente, il vaginismo può causare dolore e disagio durante il rapporto sessuale o anche durante l’esame ginecologico. Questo dolore può portare alla diminuzione dell’interesse per il sesso, alla riduzione della lubrificazione vaginale e, in alcuni casi, anche alla completa evitazione del sesso. Le donne con vaginismo possono anche manifestare problemi di incontinenza e di difficoltà nella stessa defecazione.
Sul piano psicologico, il vaginismo può portare a sentimenti di vergogna, colpa, ansia e frustrazione. Le donne che soffrono di questa condizione possono provare vergogna riguardo al loro corpo e alla loro sessualità, così come ansia e paura nei confronti del sesso.
Inoltre, il vaginismo può anche influire sulla vita di coppia e sulla relazione con il partner, creando tensioni e difficoltà nella comunicazione.
Il vaginismo è definito dalle coppie come “la presenza di un muro” dove dovrebbe trovarsi l’apertura vaginale. Il forte bruciore e disagio provato nei ripetuti tentativi di penetrazione, solitamente fanno si che una coppia alla fine interrompa il rapporto sessuale.
Anche se curabile, molte donne si sentono sole ed incomprese, e spesso si sentono in imbarazzo nel cercare aiuto. Questo perché il vaginismo come la maggior parte dei problemi sessuali viene molto poco discusso.
Le cause del vaginismo possono essere sia fisiche che psicologiche. Tra le cause fisiche rientrano le infezioni vaginali, la menopausa, i traumi vaginali o le cicatrici. Tra le cause psicologiche rientrano invece l’ansia, la paura del dolore durante il rapporto sessuale, la mancanza di informazioni e la presenza di traumi o di esperienze sessuali negative nel passato.
Tipologie di vaginismo
Esistono diverse tipologie di vaginismo, tra cui:
- Vaginismo primario: si verifica quando una donna non è mai stata in grado di avere rapporti vaginali a causa di una contrazione involontaria dei muscoli vaginali.
- Vaginismo secondario: si verifica quando una donna che in passato ha avuto rapporti sessuali vaginali senza difficoltà inizia ad avere difficoltà a causa di una contrazione involontaria dei muscoli vaginali.
- Vaginismo situazionale: si verifica solo in determinate situazioni, ad esempio con un partner specifico o in una particolare posizione sessuale.
- Vaginismo generalizzato: si verifica in tutte le situazioni in cui si tenta di avere rapporti sessuali vaginali.
- Vaginismo associato a cause mediche: può essere causato da problemi di salute, come infezioni vaginali, fibromi uterini o endometriosi.
Il vaginismo a livello psicologico
Sebbene il vaginismo sia spesso considerato un disturbo fisico, ci sono anche fattori psicologici che possono contribuire al suo sviluppo.
Ad esempio, l’ansia da prestazione sessuale, le paure legate alla sessualità o i traumi sessuali passati possono contribuire allo sviluppo del vaginismo.
Inoltre, il vaginismo può essere il risultato di una combinazione di fattori fisici e psicologici. Ad esempio, se una donna ha sperimentato dolore durante la penetrazione a causa di una condizione medica, potrebbe sviluppare un riflesso di contrazione muscolare involontaria per evitare ulteriori danni o dolore, che potrebbe peggiorare nel tempo e diventare vaginismo.
Il vaginismo può essere trattato con successo attraverso una combinazione di terapie fisiche e psicologiche, come l’utilizzo di dilatatori vaginali per allentare la tensione muscolare e la terapia sessuale per aiutare a gestire l’ansia e le paure legate alla sessualità.
Il vaginismo e l’abuso sessuale
L’abuso sessuale può avere molteplici effetti negativi sulla salute mentale e sessuale delle persone, tra cui il vaginismo.
In particolare, le donne che hanno subito abusi sessuali possono sviluppare un riflesso di contrazione involontaria dei muscoli vaginali durante la penetrazione, come forma di protezione contro ulteriori danni o lesioni.
Il vaginismo può essere un sintomo di disturbo da stress post-traumatico (PTSD) in seguito all’abuso sessuale, o può essere associato ad altri disturbi dell’umore, come la depressione o l’ansia.
Tuttavia, è importante notare che non tutte le donne che hanno subito abusi sessuali sviluppano vaginismo. La risposta al trauma sessuale è altamente individuale e dipende da molteplici fattori, tra cui la gravità e la durata dell’abuso, l’età in cui è avvenuto e il supporto emotivo e psicologico ricevuto dopo l’evento.
Il trattamento del vaginismo nelle donne che hanno subito abusi sessuali richiede spesso una particolare attenzione e cura da parte degli operatori sanitari, poiché può essere associato ad ansia, paura, vergogna e altri problemi emotivi che richiedono un approccio integrato che coinvolga psicologi e terapeuti specializzati.
Disturbi dell’umore collegati al vaginismo
I disturbi dell’umore, come la depressione e l’ansia, possono essere collegati al vaginismo.
Le donne che soffrono di depressione o ansia possono avere difficoltà a rilassarsi durante il rapporto sessuale e possono avere difficoltà a provare piacere sessuale. Inoltre, l’ansia associata al vaginismo può causare una sensazione di panico o di incapacità di controllare i propri muscoli vaginali.
D’altra parte, il vaginismo può causare stress e frustrazione, che possono portare a disturbi dell’umore come la depressione.
La difficoltà a avere rapporti sessuali può anche portare a problemi di relazione e isolamento sociale, che possono peggiorare ulteriormente i sintomi depressivi o ansiosi.
È importante notare che il vaginismo non è una conseguenza diretta della depressione o dell’ansia, ma è piuttosto una risposta fisica e psicologica a fattori che possono includere anche problemi di autostima, relazionali o di disfunzione sessuale.
Tuttavia, il trattamento dei disturbi dell’umore può aiutare a ridurre i sintomi di ansia e depressione associati al vaginismo, migliorando la qualità della vita sessuale e relazionale delle donne che ne soffrono. Inoltre, il trattamento del vaginismo può anche migliorare la salute mentale e il benessere generale della persona.
Il vaginismo: un circolo vizioso
Il ciclo del dolore associato al vaginismo può essere descritto come segue:
- Anticipazione dell’esperienza dolorosa: la donna che soffre di vaginismo può anticipare il dolore associato al rapporto sessuale. Questa anticipazione può causare ansia e paura.
- Contrazione involontaria dei muscoli vaginali: quando la donna viene stimolata sessualmente o quando tenta la penetrazione, i muscoli della vagina si contraggono involontariamente. Questa contrazione può essere così forte da rendere impossibile la penetrazione.
- Dolore durante la penetrazione: a causa della contrazione dei muscoli vaginali, la penetrazione può diventare molto dolorosa. Questo dolore può ulteriormente aumentare l’ansia e la paura della donna.
- Evitamento del rapporto sessuale: a causa dell’esperienza dolorosa, la donna può evitare il rapporto sessuale. Questo evitamento può portare a problemi di intimità e di relazione.
- Continua anticipazione del dolore: a causa dell’esperienza dolorosa passata, la donna può continuare ad anticipare il dolore durante il rapporto sessuale. Questa anticipazione può ulteriormente aumentare l’ansia e la paura e aggravare il ciclo del dolore.
Il ciclo del dolore associato al vaginismo può diventare un circolo vizioso che porta a un aumento dell’ansia e del dolore.
Approccio al trattamento
Poiché il vaginismo è una condizione involontaria che si autoalimenta, normalmente non si risolverà spontaneamente se non adeguatamente affrontato.
Fortunatamente, attraverso un trattamento efficace, le donne affette da vaginismo possono imparare a controllare e rilassare la reazione muscolare iperreattiva che è caratteristica della condizione.
Mentre la donna (e il suo partner) possono stabilire un primo contatto con un sessuologo/psicologo, l’approccio terapeutico ottimale è multidisciplinare, e di solito prevede la collaborazione di uno o più altri professionisti della salute.
Di solito è necessario rivolgersi a un ginecologo/medico di base per l’indagine sui fattori di rischio fisiologici.
Dopo il consulto ginecologico, è spesso opportuno che il cliente venga valutato e curato da un fisioterapista specializzato nella funzionalità del pavimento pelvico. Il fisioterapista svolge un ruolo fondamentale nell’addestrare e supportare la cliente nel rilassamento muscolare e nell’utilizzo dei dilatatori vaginali. Questo processo avviene in concomitanza con il lavoro del sessuologo che si concentra sulle questioni psicologiche del dolore, del sesso, dei fattori individuali e delle dinamiche di coppia.
Valentina Cicerone
Tirocinante di psicologia presso
Studio BURDI
Continua
Superare l’amaxofobia (la paura di guidare)
Metodo di approccio di psicoterapia dello Studio BURDI
per
SUPERARE L’AMAXOFOBIA (LA PAURA DI GUIDARE)
Cos’è l’amaxofobia
L’amaxofobia, o la paura di guidare, è un disturbo che può presentarsi come fobia singola o può inserirsi in un quadro psicologico più ampio, spesso correlato ad altre fobie, quali l’agorafobia, la claustrofobia e ad altri disturbi ansiosi, come l’ansia generalizzata, l’ansia sociale, l’ansia di separazione.
In alcuni casi, l’amaxofobia può essere la conseguenza di un trauma in seguito ad un incidente, vissuto in prima persona o al quale si è assistito.
E’ interessante notare che la paura di guidare non è una paura senza fondamento, esiste obiettivamente un potenziale pericolo associato alla guida di un veicolo, di cui è bene essere consapevoli, tuttavia nell’amaxofobia la paura prende delle proporzioni eccessive e invalidanti, poiché il soggetto prospetta eventi catastrofici e irreparabili, spesso irrealistici.
Essa si traduce in sintomi quali tremori, sudore, nodo alla gola, battiti accelerati, difficoltà di respirazione, associate a idee angoscianti, che possono poi sfociare in veri e propri attacchi di panico.
In generale le persone che hanno questo disturbo utilizzano delle strategie di evitamento, quali l’utilizzo di altri mezzi di trasporto o la dipendenza per gli spostamenti da amici e familiari.
Tuttavia laddove le strategie di evitamento siano difficilmente praticabili, l’amaxophobia può risultare fortemente invalidante.
In molti casi la persona, terrorizzata dalla guida, finisce per dipendere da altri soggetti per i propri spostamenti, ottenendo in tal modo (più o meno consapevolmente) la vicinanza funzionale delle persone care, oppure finisce per isolarsi e chiudersi in un perimetro di oggetti vicini e familiari, potenzialmente sicuri.
Sebbene il risultato sia lo stesso in termini di incapacità oggettiva a intraprendere la guida, in pratica l’amaxofobia può sottendere paure diverse correlate alla situazione di trovarsi da soli nella gestione del mezzo: paura di perdere il controllo, di investire e/o uccidere qualcuno, di causare un incidente grave, paura della velocità, paura di non poter fuggire, paura di attraversare viadotti o tunnel, paura di allontanarsi da casa.
Possiamo dire che vi è globalmente una distorsione cognitiva in cui vi è e una sovrastima della probabilità che un pericolo importante si presenti e una sottostima della propria capacità di gestire la situazione. Anzi, in molti casi il soggetto amaxofobo, identifica nella propria persona la fonte del pericolo stesso.
L’amaxofobia va dunque a toccare una rappresentazione, quella della propria incompetenza nella gestione di una situazione specifica che implica un ruolo di “conducente”. Per questa ragione essa ha spesso anche un valore simbolico rispetto ad altri ambiti della vita.
Infatti non è trascurabile l’impatto nell’insorgenza di tale fobia, di aspetti di attribuzione di ruolo sviluppati in particolari contesti familiari e/o culturali, che devono essere presi in considerazione in modo privilegiato nell’approccio terapeutico del disturbo stesso.
Infine, nell’amaxofobia si attiva in maniera dirompente il senso della propria fragilità esistenziale, spesso rimosso in altre attività della vita quotidiana,
Questi aspetti rivelano da un lato una problematica nell’investimento interno: l’utilizzo di un mezzo di trasporto solidale con il proprio corpo, è percepito come estensione di sé e pertanto inaffidabile, incontrollabile e potenzialmente auto ed etero-lesivo. Dall’altro evidenziano anche una problematica nell’investimento esterno, dove la frustrazione derivante dagli oggetti esterni, potrebbe essere verosimilmente all’origine del proprio senso di inadeguatezza e di incompetenza.
Come si cura
Per il trattamento dell’amaxofobia, dal punto di vista sintomatico, è di fondamentale importanza aiutare il paziente a trovare quegli strumenti idonei a ripristinare il senso di sicurezza e di fiducia in sé stesso e nella propria capacità di investirsi positivamente in una realtà più ampia del perimetro consolidato.
In particolare la psicoterapia può aiutare il paziente a riacquisire la consapevolezza delle proprie competenze
-valorizzandone il potenziale
– evidenziando le distorsioni cognitive proprie, familiari e/o culturali che possono avere favorito il consolidamento del disturbo
-stimolando il superamento progressivo di alcune limitazioni che il paziente vive nella sua quotidianità e favorendo in questo modo la qualità e la quantità degli investimenti esterni
Il lavoro psicoterapeutico può essere coadiuvato dall’ipnoterapia, la cui efficacia è stata dimostrata nel trattamento di diverse fobie specifiche. Questa permette infatti di generare sicurezza nel paziente, favorendo l’accesso alla consapevolezza delle proprie paure e ad un maggiore controllo dei propri stati ansiosi a queste connessi (1).
A supporto della psicoterapia può inoltre essere presa in considerazione la terapia in realtà virtuale, VRT (Virtual Reality Therapy), che consiste nell’immergere il paziente in un’esperienza virtuale in 3D. L’esperienza di guida così riprodotta consente al paziente di affrontare progressivamente le situazioni ansiogene in un ambiente sicuro.
Qualora l’insorgenza del disturbo fosse correlata ad un’esperienza traumatica, è bene piuttosto considerare trattamenti terapeutici specifici per il trattamento del trauma come la terapia di desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) od il Somatic experiencing(2) mirate al trattamento dello stress post-traumatico e alla riduzione della carica emotiva dei ricordi disturbanti.
Sintesi a cura di:
Dott.ssa Laura Cecchetto
Tirocinante di Psicologia presso Studio BURDI
- Spiegel, E.B. (2016) International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 64(1), 45-74
- Levine, P. A. (2010). In an unspoken voice: How the body releases trauma and restores goodness. North Atlantic Books.

Superare l’ansia anticipatoria
Metodo di approccio di psicoterapia dello Studio BURDI
per
SUPERARE L’ANSIA ANTICIPATORIA
Cos’è l’ansia anticipatoria
L’ansia anticipatoria è spesso un sintomo correlato ad altri disturbi ansiosi, come l’ansia generalizzata, l’ansia sociale, l’ansia di separazione, che può anche essere correlato a particolari tipo di personalità come ad esempio la personalità evitante o dipendente.
In generale si può definire come una forma di angoscia proiettata esclusivamente verso il futuro e più precisamente, come per altri disturbi di ansia, si manifesta come una paura di essere sorpresi da un evento “orribile” (secondo il sistema di valori di chi la prova) in grado di generare a sua volta una paura insostenibile: si tratta quindi di una paura della paura.
Il sintomo dell’ansia anticipatoria sussiste in quanto, seppur generando una grande sofferenza, fornisce una momentanea illusione di poter scampare all’evento orribile e alla paura, preoccupandosene anticipatamente.
Nel contesto culturale in cui viviamo anticipare il futuro per essere pronti alle eventualità della vita è un atteggiamento considerato normale. Immaginare di aver previsto e di essere quindi in grado di gestire le varie possibilità ha un effetto rassicurante e consente di affrontare con un certo margine di serenità sia lo svolgimento delle attività quotidiane, sia altre attività più eccezionali come fare una presentazione in pubblico, partire in viaggio, cambiare un lavoro etc.
Considerate quindi le premesse culturali che in qualche modo coadiuvano la comparsa di questo tipo di disturbi, nel caso specifico le persone che soffrono di ansia anticipatoria sono persuase del fatto che naturalmente l’eventualità più probabile nel futuro sarà anche la peggiore.
Queste persone immaginano sistematicamente che il peggio sarà ciò che sicuramente accadrà loro rimanendo in questo modo sommerse dalle sensazioni di impotenza e di orrore che scaturiscono dalle proprie proiezioni.
Inoltre molto spesso l’evento temuto finisce proprio per concretizzarsi a causa dell’ansia e del turbamento che pervadono la persona nel momento in cui si trova nella situazione da affrontare e il cui scenario catastrofico era stato immaginato precedentemente.
Bloccate e sofferenti dal punto di vista psicologico, per evitare la paura il paziente mette in atto una serie di strategie disfunzionali (evitamento delle situazioni, ricerca permanente del sostegno esterno etc.)che hanno come risultato quello di amplificare la sensazione di mancanza di controllo e quindi la paura stessa, inficiando fortemente la qualità della vita.
Come si cura
Per poter affrontare le problematiche invalidanti legate all’ansia anticipatoria e alla paura è bene tener conto del fatto che la paura è il risultato di un meccanismo di difesa ancestrale, messo in atto dalla componente più arcaica del nostro cervello sulla quale la parte più evoluta ha un debole controllo. Inoltre, è necessario considerare che l’ansia anticipatoria, seppur disfunzionale, è a sua volta una strategia di difesa dalla paura stessa.
Lavorare sulla razionalizzazione delle proprie paure risulta quindi molto spesso infruttuoso, mentre risalire alle cause della paura può da solo non essere sufficiente a scardinare una strategia difensiva consolidata da tempo.
Gli approcci terapeutici oggi più efficaci per il trattamento dei disturbi ansiosi, lavorano pertanto su altri aspetti che riguardano l’accettazione delle proprie emozioni e la realizzazione concreta attraverso il vissuto, di un nuovo modo di relazionarsi con la realtà che va a scardinare operativamente le vecchie strategie disfunzionali (1). Illustriamo qui brevemente i punti principali di tali approcci:
–Il riconoscimento della funzionalità del sintomo ansioso come strategia di difesa dalla paura.
Il riconoscimento della funzione strategica di ciò che si sta vivendo, consente una parziale distanziamento dal sintomo, nel nostro caso l’ansia anticipatoria, e apre in qualche modo all’esistenza di altre strategie possibili. Questo lavoro di consapevolezza può essere coadiuvato dalla compilazione di un diario di bordo, supervisionato dal terapeuta.
–Il lasciare lo spazio alla paura e entrare in contatto con le sensazioni che anche a livello fisico questa genera.
Accettare di avere paura e lasciare a questa emozione lo spazio di esistere, consente di allentare le tensioni aggravate dai tentativi infruttuosi di rimuoverla.
Particolarmente rilevanti per lo sviluppo di tale attitudine sono i protocolli terapeutici mindfulness-based.
Diversi studi di neuroscienze hanno in effetti messo in rilievo l’importanza dello sviluppo della consapevolezza delle proprie sensazioni fisiche nel momento presente e della relazione corpo/emozioni nel ripristino di un controllo da parte del cervello più evoluto, la nostra corteccia, sul cervello primitivo.
In particolare le pratiche basate sulla mindfulness sono in grado di incrementare la capacità di regolazione delle proprie emozioni (2) ed hanno un effetto positivo sulla capacità di inibire il comportamento automatico e reattivo(3),
-Il rimodellamento della percezione della realtà e di sé stessi per attuare nuove modalità di interazione
Ciò viene realizzato favorendo nel paziente la consapevolezza che vi sono diverse rappresentazioni possibili e promuovendo l’attuazione di azioni e comportamenti concreti più funzionali, attraverso suggestioni terapeutiche.
Sintesi a cura di:
Dott.ssa Laura Cecchetto
Tirocinante di Psicologia presso Studio BURDI
- Nardone, G. (2010). Paura, panico, fobie. Ponte allegrazie.
- Tang, Y. Y. (2017). The neuroscience of mindfulness meditation: How the body and mind work together to change our behaviour.
- Pozuelos, J. P., Mead, B. R., Rueda, M. R., & Malinowski, P. (2019). Short-term mindful breath awareness training improves inhibitory control and response monitoring. Progress in brainresearch, 244, 137-163.

Superare l’ipocondria
Metodo di approccio di psicoterapia dello Studio BURDI
per
SUPERARE L’IPOCONDRIA
Cos’è l’ipocondria
La caratteristica fondamentale dell’ipocondria o ansia di malattia, è la preoccupazione o la persuasione di essere gravemente malati al minimo sintomo fisico sospetto.
L’aspetto fondamentale dell’ipocondria è che tale convinzione persiste a dispetto delle rassicurazioni mediche e di esiti diagnostici negativi.
Di fatto è corretto parlare di ipocondria solo nel caso in cui le valutazioni mediche abbiano consentito di escludere la malattia reale, sebbene vi possano essere forme di ipocondria legate ad un’ansia eccessiva in presenza di un disturbo organico non grave.
Se i problemi di salute possono essere immaginari, di fatto l’angoscia che questi generano non lo è e l’ipocondria è un serio disturbo in grado di inficiare gravemente la qualità della vita di una persona.
Cause dell’ipocondria
L’ipocondria è un disturbo complesso le cui cause possono essere difficili da stabilire.
Secondo la teoria psicoanalitica di Freud(1) all’origine dell’ipocondria vi sarebbe la frustrazione legata all’impossibilità di trovare il soddisfacimento delle proprie pulsioni in oggetti esterni; ciò comporterebbe a lungo termine l’investimento in oggetti di natura interna, nel caso particolare il corpo, il soma.
La libido, parzialmente ritirata dagli oggetti esterni viene investita nel corpo, che diventa pertanto ciò che consente di mantenere e di scaricare la propria energia pulsionale.
Il ruolo vitale assunto dal corpo in questo senso determinerebbe a lungo termine la forte preoccupazione per la sua deteriorazione e la paura della malattia.
All’origine del disturbo vi sarebbe quindi prevalentemente la frustrazione derivante dagli oggetti esterni, tipicamente vissuti di trascuratezza, un ambiente familiare assente o falsamente presente nella fase dello sviluppo.
Da notare che l’ipocondria può essere accentuata in situazioni di allontanamento dagli oggetti familiari e può riguardare il proprio corpo o quello delle persone care, dei figli.
Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante in quanto pone l’accento sulla possibile trasmissione familiare/transgenerazionale dell’ipocondria e del modello di relazione oggettuale tipicamente ipocondriaco.
Ciò delinea pertanto tra le possibili cause dell’ipocondria, anche quella di un disturbo mutuato da figure parentali o figure significative dell’ambiente familiare.
Infine il ri-orientamento dell’investimento oggettuale da esterno ad interno, può insorgere anche come conseguenza di un trauma, legato ad una minaccia esistenziale personale o assistita in una fase precoce dello sviluppo: l’aver sofferto di una malattia o l’aver assistito alla malattia grave o al decesso di una persona cara.
La consapevolezza precoce della morte e della precarietà esistenziale, in assenza degli strumenti per fronteggiare le angosce che queste generano, possono tradursi in un ritiro dell’investimento esterno e in un ripiegamento sull’oggetto interno, il corpo, nel tentativo di ripristinare una forma di controllo che di fatto rimane permanentemente insoddisfatta.
Sintomi dell’ipocondria
L’ipocondria si manifesta in maniera costante con l’eccessiva preoccupazione per la presenza di dolori di vario tipo (crampi muscolari, dolori viscerali etc.) o alterazioni fisiche di lieve entità (macchie sospette, raffreddori etc.), ma si può manifestare anche sotto forma di vere e proprie crisi di angoscia.
La minima manifestazione fisica è interpretata dall’ipocondriaco come sintomo di una malattia grave, potenzialmente mortale.
Spesso è proprio la paura di essere malati a generare alcune reazioni fisiche (giramenti di testa, palpitazioni), fino alla crisi di angoscia acuta o all’attacco di panico.
Per essere rassicurato il paziente ipocondriaco consulta spesso siti internet e blog che trattano le tematiche della salute o si sottopone a ripetuti controlli medici.
Sebbene più raramente, alcune persone ipocondriache evitano i medici, con il rischio di non rilevare e non curare una malattia reale.
Per chi soffre di ipocondria, il timore della malattia costituisce un elemento essenziale della propria identità, attraverso cui questa si esprime, per cui spesso i sintomi diventano una forma di risposta agli stress esistenziali.
Cura dell’ipocondria
La presa di coscienza del disturbo è da considerarsi già un primo passo del processo terapeutico.
La psicoterapia può aiutare in prima istanza il paziente a controllare la sintomatologia, attraverso il rispetto di una serie di regole e l’applicazione di alcune strategie.
In seconda istanza la psicoterapia può consentire al paziente di assumere una nuova consapevolezza del disturbo in relazione alla propria storia personale e familiare, e ad individuare quali elementi della propria vita presente siano in grado di alimentare o ridurre i sintomi, agendo su di questi.
In alcuni casi la psicoterapia, può operare nel senso di una maggiore familiarità con l’idea della malattia e dell’ineluttabilità della morte, incoraggiando ad esempio il paziente a recarsi al cimitero per esporsi alla realtà e ridurre le ruminazioni che di fatto non sono in grado di evitare il pericolo.
Relativamente alle regole e alle strategie di controllo dei sintomi è molto importante che il paziente impari a sottrarsi alla consultazione compulsiva di pagine di informazione e blog sulla salute in internet, e a resistere al desiderio, magari rimandandolo, di effettuare ripetute attività di autoverifica del proprio stato di salute, come sentirsi il polso, controllare la temperatura etc. che non fanno altro che alimentare l’ansia, il timore della malattia e la prospettiva di scenari catastrofici.
Nel quadro del lavoro terapeutico è di importanza strategica lo sviluppo nel paziente di un atteggiamento di osservatore rispetto al decorso dei sintomi, in particolare imparando a riconoscere quando questi si acuiscono, in corrispondenza di quali eventi/situazioni. Può essere utile eventualmente annotare quotidianamente alcune di queste osservazioni. Diventare l’osservatore attivo e non passivo del proprio sintomo, consente infatti di iniziare a mettere una certa distanza tra sé e il sentimento di paura che questo genera.
Questa qualità di osservazione può essere favorita in particolare, oltre che dal dialogo psicoterapeutico, dai protocolli Mindfulness per la riduzione dell’ansia e dello stress (Mindfulness Based Stress Reduction), che hanno ottenuto notevoli riscontri anche nel trattamento dell’ipocondria (2).
Anche la pratica di attività fisica costituisce un valido aiuto nel processo terapeutico. Questa infatti può contribuire a ritrovare sensazioni fisiche reali e a recuperare una relazione di fiducia con il corpo e una visione di questo come veicolo di benessere e non solo di malattia. Particolarmente indicate sono la pratica dello yoga e delle arti marziali (3), che richiedono un’elevata consapevolezza e padronanza del corpo, alcune di queste attività sono incluse di fatto nel quadro dei protocolli Mindfulness.
In generale è importante adottare una buona igiene di vita e trovare altri centri di interesse oltre alla salute, fissandosi ad esempio degli obiettivi diversificati.
Infine laddove l’ipocondria si potesse correlare ad un vissuto traumatico, è utile il ricorso alla terapia di Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) una terapia mirata al trattamento dello stress post traumatico basata sull’utilizzo di movimenti oculari ed altre tecniche di stimolazione con lo scopo di ridurre la carica emotiva di ricordi disturbanti.
Sintesi a cura di:
Dott.ssa Laura Cecchetto
Tirocinante di Psicologia presso Studio BURDI
1.S.Freud: Introduzione al Narcisismo, Opere, Boringhieri, Vol 7
- Chappell, A. S. (2018). Toward a lifestyle medicine approach to illness anxiety disorder (formerly hypochondriasis). American Journal of Lifestyle Medicine, 12(5), 365-369.
3 Zhang, J., Qin, S., Zhou, Y., Meng, L., Su, H., & Zhao, S. (2018). A randomized controlled trial of mindfulness-based Tai Chi Chuan for subthreshold depression adolescents. Neuropsychiatric disease and treatment. Neuropsychiatric disease and treatment, 14, 2313.
Continua